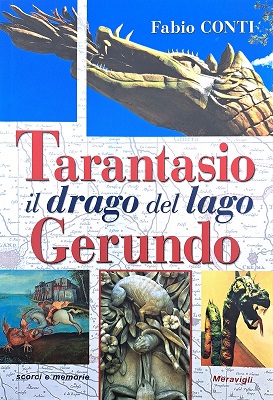
| * HOME * | * FORTEANA * |
I Draghi mi hanno sempre attratto come elementi mitologici.
Sembrano in grado di unire malizia umana e bestialità,
saggezza malevola e spietatezza... Creature terrificanti.
(J. R. R. Tolkien)
Il lago che non c'è più - Tarantasio - Le sue (ig)nobili origini - La fine - L'aspetto e i simboli - Le costole
Il lago che non c'è più
L'argomento draghi è veramente complesso e vasto.
Questo criptide,
quest'animale secondo la scienza immaginario, è curiosamente stato sempre presente in
tutte le culture.
I laghi sembrano essere particolarmente vocati per ospitare questi mostri: abbiamo infatti il drago del
lago d'Orta, quello del lago di Nambino e in Croazia il drago Murin fornisce adirittura il nome al suo lago:
"Zmajevo oko", "Occhio del drago".
Nel nostro caso stiamo parlando non solo di un drago che non c'è più, ma anche di un lago che non c'è più: il
Lago Gerundo.
Wikipedia dà incerto anche questo, o perlomeno lo dà per esistente nella preistoria, ma non essendoci fonti storiche precise,
negli ultimi secoli lo definisce come una zona paludosa, ghiaiosa,
dove l'ex lago compreso tra l'Adda e il Serio in parte è stato bonificato e in parte si è drenato per conto proprio.
Come al solito per parlare di un argomento partirò da un libro: "Tarantasio il drago del lago Gerundo" di Fabio Conti.
Il libro è la logica continuazione del precedente "Lago Gerundo tra storia e leggenda" dello stesso autore.
Tarantasio
E arriviamo finalmente al nostro drago
Tarantasio:
si comincia con le origini sia del nome che del drago stesso.
Se il nome si presta ad un'assonanza con una altro terribile e ben più famoso mostro, la provenzale
Tarasca,
che però come iconografia non assomiglia per niente ad un drago come Tarantasio,
Conti si spinge così a cercare le origini in una (tutto sommato plausibile) radice indoeuropea, sanscrita per la precisione:
taranta-h che significa "mare". Per quanto suggestiva l'ipotesi è un po' remota.
Ecco quindi che stando un po' più sul pratico, seppur nell'ambito mitologico, il nostro drago potrebbe condividere l'etimo con la città di
Taranto, quindi deriverebbe da
Taras
con il suo tempio di Poseidone e il suo anfiteatro dedicato a Dioniso.
Quest'ultimo potrebbe essere stato il vero "mostro" da sradicare nel territorio, ovvero gli ultimi residui pagani da combattere da parte dei cristiani.
Oltre all'etimologia del nome "Tarantasio" esiste inevitabilmente anche una toponomastica che fa riferimento al drago,
nonché un'altra che fa riferimento al nome del lago Gerundo.
Insomma stiamo parlando di qualcosa profondamente radicato nel territorio, e se una volta erano terrorizzati dal fiato nauseabondo e mefitico del drago
(identificato da Fabio Conti nelle esalazioni sulfuree delle paludi residue del lago), adesso il buon Tarantasio è guardato con simpatia e caricaturizzato in iniziative per l'infanzia.
Insomma è un po' come il "Prezzemolo", la mascotte di Gardaland, della Lombardia.
L'aggettivo mefitico per definire il fiato del drago non è un caso, come ci dice
Wikipedia:
Mefite è una divinità italica legata alle acque, invocata per la fertilità dei campi e per la fecondità femminile.
Il nome Mefitis è sicuramente osco, con la caratteristica -f- intervocalica, e deriva forse da "medio-dluitis", donde "mefifitis" e quindi Mefitis,
cioè "colei che fuma nel mezzo" oppure da "Medhu-io" cioè "colei che si inebria"[2] o ancora - sembra con maggiore probabilità - "colei che sta nel mezzo",
ovvero entità intermedia fra cielo e terra, fra morte e vita. [...]
La presenza di Mefite si riscontra anche fuori dell'area osco-sabellica: a Cremona, a Lodi Vecchio [...]
I luoghi di culto di Mefite sono situati quasi sempre in un ambiente caratterizzato dalla presenza di acque fluviali o lacustri.
È stato ipotizzato che, da divinità legata alle acque e alle sorgenti in generale,
dopo la romanizzazione dell'Italia sia stata connessa maggiormente e poi esclusivamente alle esalazioni emanate da mofete e da acque sulfuree
o corrotte come quelle stagnanti, che essa doveva impedire, o comunque a luoghi contrassegnati da fenomeni vulcanici.
Laddove Wikipedia mi dà un "Senza fonte" rispetto alla presenza del culto di Mefite in quel di Cremona, Fabio Conti fornisce invece un'indicazione precisa: nel museo di Cremona c'è un'ara dedicata a questa dea proveniente dal comune di Genivolta, e siamo a circa otto chilometri da Soncino che come vedremo è un luogo centrale per Tarantasio.
Le sue (ig)nobili origini
Se Soncino e la sua rocca
sono in provincia di Cremona, l'origine del mostro-drago è in parte veneta perché nasce da un mostro-uomo:
Ezzelino III da Romano.
La leggenda narra che questo feroce condottiero filoimperiale dopo aver conquistato buona parte del Veneto attuale,
mentre si stava espandendo in Lombardia, fu sconfitto proprio a Soncino.
Non si capisce quanto ci sia di leggenda e quanto di realtà, ma su di lui come prigioniero si accanirono in modo disumano,
forse anche per vendicarsi di come lui aveva agito a sua volta precedentemente e, per farla breve,
il cadavere del malvagio Ezzelino si è poi reincarnato sotto forma di mostro, e come drago ha poi continuato le sue nefandezze.
Ezzelino "temuto addirittura più del diavolo («Hic plus quam diabolus timebatur»)" sembra anche che sia stato sepolto sul proprio tesoro,
il che ci richiama un po' i draghi di Tolkien.
Conti è piuttosto inventariale nel suo libro e riporta tutte le possibili origini pagane del mito, accennate poc'anzi,
però questa è la leggenda più accreditata, più condivisa.
La fine
Qui la faccenda si fa estremamente più articolata e incerta perché pare che l'abbiano ucciso:
San Cristoforo, San Colombano, Bernardo de' Talenti, Federico Barbarossa, Uberto Visconti e mi sto sicuramente dimenticando altri nomi.
Personalmente trovo interessante notare che se da una parte abbiamo dei santi che giustificherebbero l'ipotesi mitologico-pagana del mito,
dall'altra abbiamo un Federico Barbarossa che proprio tanto d'accordo non andava con la chiesa
(vedi ad esempio la lotta per le investiture), e
Uberto Visconti che,
cito testualmente da Wikipedia, "Venne tacciato di mancanza di sentimento religioso durante il concistoro di Clemente IV a Viterbo da parte dei Torriani
al fine di impedire l'elezione di Ottone Visconti, suo figlio, ad arcivescovo di Milano".
L'aspetto e i simboli
E arriviamo così all'aspetto di Tarantasio.
Come riporta lo storico Paolo Morigia:
Andò adunque il coragioso Uberto contro il mortifero Drago armato non tanto di ferro, quanto di fortezza d’animo, di destrezza, & d’ingegno, et al fine felicemente l’ucise, et liberò la sua patria con gloria eterna di lui. Da questo Uberto ha havuto origine casa Visconte
L'epica impresa di Uberto ha dato inizio alla casa viscontea e al suo simbolo: il biscione.
Anche se Wikipedia
ci gira attorno senza citarlo, sembra plausibile che quanto riportato da Paolo Morigia, per quanto leggendario, sia corretto.
Come si può vedere dal link di Wikipedia il simbolo è poi stato ereditato da molti loghi moderni, dall'Alfa Romeo alle aziende berlusconiane.
Viceversa il famoso Cane a sei zampe
dell'Eni opera di Luigi Broggini è stato concepito in modo originale ma fa riferimento sempre al nostro Tarantasio (anche se Wikipedia è un po' restìa ad ammetterlo).
L'aspetto più corretto sembra essere però quello più storico, quello dei Visconti: un enorme serpente che sputa fuoco.
L'immagine del serpente che ingoia un uomo è però anche un simbolo dell'iniziazione, delle morte iniziatica: è la grotta di Trofonio,
nella quale si entra dopo aver bevuto l'acqua del Lethe per dimenticare la vita umana, e l'acqua di Mnemosyne per ricordare ciò che si apprende nell'altro mondo.
Curiosamente un film demenziale come "Forbidden Zone" riporta lo stesso simbolismo come ho fatto notare
in questa pagina.
Questo aspetto serpentiforme è confermato anche da alcuni affreschi, tra i quali forse il più famoso è quello
dell'Abbazia di San Pietro al Monte,
a Civate in provincia di Lecco.
Curiosamente assomiglia anche al drago di Pisanello presente nella
Cappella Pellegrini della basilica di Sant'Anastasia a Verona.
Le costole
Per i poveri miscredenti non ci saranno mai prove tangibili dell'esistenza dei draghi e di Tarantasio in particolare.
Per gli altri avevamo fino al XVIII secolo lo scheletro intero del drago presso la chiesa di Sant'Andrea a Lodi.
Poi è andato perso così come la costola che era conservata nella chiesa di San Cristoforo a Lodi.
Da poter ammirare ancora oggi abbiamo invece la costola presente nella chiesa di San Bassiano a Pizzighettone (Cremona),
quella della chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore a Bergamo
e infine nella stessa provincia quella del santuario della Natività della Beata Vergine a Sombreno.
Per le spiegazioni ufficiali si va ovviamente dai mammuth alle balene.
Il che come veronese mi ricorda molto la "nostra" costola, quella appesa al volto che conduce da piazza delle Erbe a piazza dei Signori:
ufficialmente l'ho sempre sentita definire di balena, però chissà ... visto che Ezzelino da Romano qualche danno l'ha fatto anche nelle nostre zone,
qualcuno potrebbe essersi preso la soddisfazione di appenderne una costola in pieno centro, nel foro romano della città.
Sempre fuori regione Lombardia, quindi fuori zona (ma non troppo) per il lago Gerundo c'è anche la, per noi meno famosa, costola del duomo di Modena,
che se pure ben esposta è forse meno visibile.
Ad un certo punto del libro Fabio Conti azzarda anche un collegamento tra la leggenda di Tarantasio e i coccodrilli,
in particolare quelli esposti nelle chiese dei quali ho parlato
in questa pagina.
Dal punto di vista simbolico posso essere d'accordo, però come datazione non ci siamo del tutto: i coccodrilli sono leggermente più recenti,
se per Tarantasio-Ezzelino parliamo del XIII secolo, per (ad esempio) i coccodrillo delle Grazie a Mantova parliamo del XV o XVI secolo.
Da una parte abbiamo una leggenda medievale, dall'altra le Wunderkammer rinascimentali (e anche oltre).
Chiudo il discorso con un solo un accenno ad un altro libro di cui avrò occasione di parlare più dettagliatamente in futuro:
"Guida ai draghi e mostri in Italia" di Umberto Cordier.
In quest'altro volume Cordier dedica un intero capitolo a Tarantasio, ma parla sempre esplicitamente di "draghi del Gerundo",
al plurale.
Perché certe strade non vanno percorse.
Perché le mappe una volta dicevano "ci sono i draghi qui".
Adesso non lo dicono, ma non vuol dire che i draghi non ci siano
(Lorne Malvo, "Fargo")
Autore: Fabio Conti
Titolo: Tarantasio il drago del lago Gerundo
Editore: Meravigli; Edizione standard
Copertina: brossura
Pagine: 192
Anno di pubblicazione: Febbraio 2024
Dimensioni: 14,3 × 21 cm
EAN: 978-8879555289
Prezzo: 18 Euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| * HOME * | * FORTEANA * |