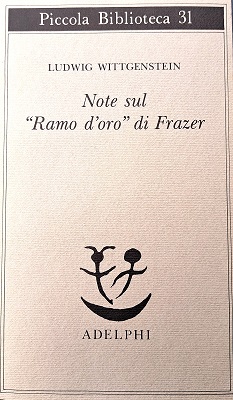
| * HOME * | * LIBRI * |
Ultimo aggiornamento: 08 Marzo 2025 (Ventôse - Mouron)
È che uno dei malintesi che dominano la nozione di biblioteca
è che si vada in biblioteca per cercare un libro di cui si conosce il titolo.
[...] ma la principale funzione della biblioteca,
almeno la funzione della biblioteca di casa mia
e di qualsiasi amico che possiamo andare a visitare,
è di scoprire dei libri di cui non si sospettava l'esistenza,
e che tuttavia si scoprono essere di estrema importanza per noi.
(Umberto Eco, "De bibliotheca")
Di cosa si tratta - Ludwig Wittgenstein - James George Frazer - Considerazioni filosofiche sull'antropologo - Considerazioni antropologiche sul filosofo
Di cosa si tratta
Per quello che mi riguarda questo libro appartiene alla categoria definita da Eco:
"libri di cui non si sospettava l'esistenza, e che tuttavia si scoprono essere di estrema importanza per noi".
L'autore è famosissimo, uno dei più importanti filosofi dello scorso secolo, però le note in questione sono praticamente sconosciute,
sono state scoperte postume e solo successivamente assemblate, la prima edizione di questo libretto risale a sedici anni dopo la sua morte, nel 1967.
Dico assemblate perché tecnicamente non sono nate come libro, ed in effetti l'effetto finale è "a braccio", ricorda molto Nietzsche.
Insomma anche se è un Adelphi relativamente recente, ci sta bene in questa lista di libri un po' fuori dallo standard, un po' originali.
Soprattutto se pensiamo che si tratta di un filosofo che ha dato un contributo importante alla storia della filosofia mondiale,
che fa il mazzo ad un antropologo che ha dato un contributo importante alla storia dell'antropologia mondiale.
Siccome non so qual è la preparazione, il tipo di cultura di chi arriva a leggere le mie umili paginette,
mi sento sempre un po' in dovere di dare qualche ragguaglio.
Se però conoscete Wittgenstein meglio di me (ci vuole poco) potete saltare il prossimo paragrafo, e se poi conoscete meglio di me anche Frazer
potete andare direttamente alle
"Considerazioni antropologiche sull'antropologo".
Ludwig Wittgenstein
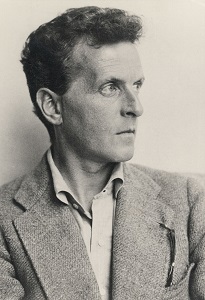
Su Wikipedia alla voce Ludwig Wittgenstein troviamo che "è stato un filosofo e logico austriaco, il cui ambito di studio era incentrato soprattutto sulla logica, sulla filosofia del linguaggio, della mente e della matematica, considerato - specialmente nel mondo accademico anglosassone - uno dei massimi pensatori del XX secolo". In vita ha pubblicato una sola opera il "Tractatus logico-philosophicus", la cui lettura sembrerebbe preclusa ad un inesperto come me, per cui neanche ci provo. Mi accontento delle spiegazioni che si trovano in rete, delle conclusioni e delle sintesi che egli stesso fa come ad esempio, una su tutte, quella della prefazione:
Tutto il senso del libro si potrebbe riassumere nelle parole: Tutto ciò che può essere detto si può dire chiaramente; e su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere.
Dopo una conclusione del genere l'autore poteva continuare a fare il filosofo?
Per logica no, e infatti coerentemente si è messo a fare dell'altro.
Poi col tempo ci ha ripensato e così si distingue un secondo periodo, una seconda fase di Wittgenstein,
ma anche questa è sempre e comunque subordinata alla logica.
Ed è questo che ci interessa sapere per le note in questione: anche qui è la logica a comandare, non la "validità scientifica"
(che dovrebbe peraltro essere soggetta anch'essa alla logica, ma spesso non lo è).
James George Frazer
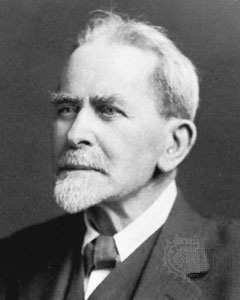
Avevo già accennato alla figura di James George Frazer
in questa pagina sul lago di Nemi.
Se Wittgenstein ha pubblicato solo il Tractatus, Frazer pur avendo più pubblicazioni al suo attivo, è famoso sostanzialmente solo per il monumentale
"Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione".
In questo caso, a differenza del Tractatus, posso dire di averlo letto, ma solo quella versione che Wikipedia chiama "abbreviazione in un volume",
tomo però già di suo bello corposo, tanto che non oso pensare all'opera completa in ben 12 volumi.
Frazer è stato un esponente di punta dell'evoluzionismo in antropologia,
quindi volendo scrivere un'opera sulla magia e sulle tradizioni nella quale oltre a raccogliere dati voleva anche fornire un quadro d'insieme, una spiegazione,
una classificazione, è dovuto ricorrere inevitabilmente a concetti di superstizione, primitivismo,
di ingenuità dettate dall'arretratezza tecnologica per quei popoli che non condividevano lo stile di vita occidentale.
Insomma il nostro antropologo parte dalla classica visione illuminista/positivista de "le magnifiche sorti e progressive" che oggi viene vista come un po' arrogante, supponente e superata perlomeno in antropologia.
Detto questo però bisogna riconoscere a Frazer il merito indiscutibile di aver raccolto e messo assieme una serie di riti, credenze, magie, tradizioni che rendono quest'opera imprescindibile.
Personalmente trovo una certa affinità con l'opera di Giuseppe Bellucci del quale ho parlato in
questa pagina
su un catalogo di una mostra, e in
quest'altra pagina
sulla sua collezione esposta nel museo archeologico di Perugia.
Anche Bellucci come Frazer infatti considerava superstizioni quelle degli amuleti che ha raccolto in tutta la sua carriera,
però al di là della sua opinione è riuscito a mettere insieme una raccolta veramente importante e significativa,
e molto probabilmente questi oggetti col loro significato sarebbero andati persi se non fosse stato per lui.
Considerazioni filosofiche sull'antropologo
In base a quanto appena detto, si può facilmente immaginare che Wittgenstein non contesta assolutamente i fatti forniti dall'antropologo Frazer, bensì la loro lettura, la sua opinione su di essi. E questo il nostro filosofo lo chiarisce fin dall'incipit:
Bisogna muovere dall'errore e convincerlo della verità.
Occorre cioè scoprire la sorgente dell'errore; altrimenti non ci serve a nulla ascoltare la verità.
Essa non può penetrare se qualcos'altro occupa il suo posto.
Per convincere qualcuno della verità, non basta constatare la verità, occorre invece trovare la via dall'errore alla verità.
E qual è l'errore? L'errore è quello di considerare "errori" le concezioni magiche e religiose degli uomini.
Frazer col suo "Tractatus" ha dimostrato con la logica che sul problema ontologico e sulla metafisica in generale non si può dire niente.
Infatti anche qui non interviene su questo, bensì sul duplice aspetto della concezione e dell'usanza:
secondo Frazer l'usanza che egli spesso fa apparire bislacca deriva da un'errata concezione.
Viceversa il filosofo austriaco ci spiega che esse vengono date assieme, e che
Un simbolo religioso non poggia su una opinione. E l'errore corrisponde unicamente all'opinione.
Il vizio di forma che sta alla base è la mancata accettazione di convinzioni religiose diverse dalle proprie.
Se Frazer vede nei sacerdoti di altri culti bizzarrie, atteggiamenti primitivi o inaccettabilmente terribili, è perché
"non è in grado di immaginarsi un sacerdote che in fondo non sia un pastore inglese del nostro tempo, con tutta la sua stupidità e insipidezza".
Come il gatto di Schrödinger che è sia vivo che morto, un atto religioso può essere spiegato e non può essere spiegato.
Se l'uomo è un animale che fa anche cose da animale come nutrirsi, dissetarsi, riprodursi, e quant'altro,
fa però anche azioni peculiari che non rientrano in quest'ambito quali ad esempio gli atti religiosi in senso esteso,
ma anche piccole azioni personali che potremmo definire rituali.
I "selvaggi", i "primitivi" sono tali solo nella ristrettezza delle vedute di Frazer:
Frazer è molto più selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi, perché questi non potranno essere più distanti dalla comprensione di un fatto spirituale quanto lo è un inglese del ventesimo secolo. Le sue spiegazioni delle usanze primitive sono molto più rozze del senso di quelle usanze strette.
Wittgenstein lavora con la logica: sulle verità ultime non possiamo dire niente, per cui una visione tradizionale
(vorrei evitare di usare ancora termini come "selvaggio" o "primitivo") vale più di una visione accademica,
diciamo pure positivistica, di un antropologo inglese del ventesimo secolo.
Ecco come l'antropologo da studioso diventa oggetto di studio, da erudito a primitivo (ci sono cascato: non sono riuscito ad evitare il termine).
L'antropologia da allora si è evoluta e si è fatta onestamente queste domande, ma Wittgenstein è stato forse il primo a porsi il problema.
La logica sta dalla parte della tradizione, laddove lega insieme coerentemente la concezione con il rito, senza pretendere di dimostrare l'una o l'altro.
Contemporaneamente Wittgenstein dimostra come non ci sia quell'ingenuità che vorrebbe Frazer alla base del rito:
Frazer dice che è molto difficile scoprire l'errore nella magia - questo è il motivo per cui essa sopravvive così a lungo: per esempio un'invocazione che abbia lo scopo di attirare la pioggia prima o poi risulterà effettivamente efficace. Ma allora è davvero strano che gli uomini per tanto tempo non abbiano scoperto che prima o poi piove comunque.
Per chiudere il discorso vorrei intervenire aggiungendo del mio, vorrei spezzare una lancia per andare un po' in soccorso al buon James Frazer in almeno tre punti.
1) Innanzitutto come si è detto la sua raccolta di dati, usanze, riti, cerimonie e tradizioni resta una pietra miliare
non solo dell'antropologia, ma della conoscenza in generale.
2) C'è della gran poesia in quello che scrive, e in come lo scrive.
Non a caso parte da un quadro romantico per eccellenza:
"The Golden Bough" di William Turner.
Quando entra in certe descrizioni il borioso studioso lascia il posto all'empatico uomo, anzi di più:
non si tratta di semplice empatia, ma si percepisce a tratti una certa simpatia, un certo fascino per gli oggetti dello studio.
3) Come evoluzione di quanto appena detto, la sparo grossa e faccio il complottista (tanto non devo render conto a nessuno delle sciocchezze che scrivo):
il Frazer che "spiega la magia", che si pone al di sopra dei riti che riporta nella sua opera, è solo una finzione letteraria.
Deve presentarsi così ai suoi colleghi e al pubblico del suo tempo, ma sotto sotto solidarizza in tutto con questo mondo.
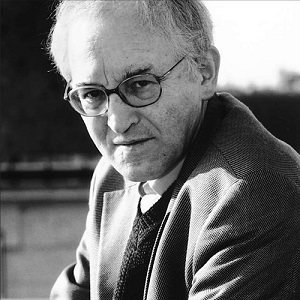
Considerazioni antropologiche sul filosofo
Nella seconda parte delle note Wittgenstein riporta diversi esempi tratti da "Il ramo d'oro" evidenziando a suon di logica gli errori espressi
nell'interpretazione di Frazer.
Solo in qualche raro caso mette in dubbio l'antichità dell'origine (quando si è in assenza di documentazione specifica),
proprio perché gli usi descritti sono logici, coerenti, possono anche essere recenti.
In buona sostanza Wittgenstein dopo aver fatto un discorso generale, ribatte caso per caso sempre con la logica,
quindi quello che poteva essere un giudizio sommario verso l'antropologo anglosassone
("Frazer è molto più selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi"), è qui esplicitato e dimostrato.
Mi sembra (ma chi sono io?) che non si possa dire altrettanto nel piccolo saggio di
Jacques Bouveresse
aggiunto alla fine del libro, forse per contrapposizione, per dialettica, per creare una sorta di bilanciamento nella discussione.
Bouveresse parte in quarta cercando di inquadrare l'autore ancor prima del contenuto,
tecnica retorica che personalmente trovo sempre discutibile: e se le note fossero state pubblicate anonime? Tanto per dire.
Non si può comprendere l'estrema severità delle osservazioni di Wittgenstein su Frazer se non si tiene conto del suo atteggiamento nei confronti della società moderna e del suo modo di concepire la posizione della filosofia all'interno di questa società.[...] L'essenza della società contemporanea è definita secondo Wittgenstein, dal progresso e dall'accumulazione, dalla produzione costante di novità e dall'incessante complicarsi del modo di vivere e di pensare, che va di pari passo col tentativo di razionalizzare questa innovazione e complicazione crescenti. Ora, il cammino del filosofo, quale lo concepisce Wittgenstein, è esattamente il contrario di tale tendenza. La filosofia non scopre e non produce alcunché di nuovo, [...] essa non cerca cose inedite ma in tutte le cose cerca la chiarezza.
Poco prima di questo passaggio troviamo l'asserzione per cui Wittgenstein "non si è occupato d'altro che di antropologia".
Insomma il messaggio è: non prendiamolo troppo sul serio con la sua logica.
Il nostro Ludwig non fa altro che calare le sue idee reazionarie rispetto al progresso vestendole con una logica eccepibile
proprio in quanto contraria al progresso.
Come dicono a Roma: me cojoni!
Ad onor del vero poi nell'analisi restituendo a Ludwig quel che è di Ludwig, Bouveresse esplicita le "note" molto bene
e lasciando anche intendere tra le righe che in fondo Frazer è stato un po' troppo un ingenuo positivista.
Insomma come si suol dire: un colpo al cerchio e un colpo alla botte.
Personalmente se avevo tre motivi, sicuramente discutibili, per andare in soccorso a Frazer,
questo saggio di Bouveresse non mi sembra il più entusiasmante che si potesse inserire nel libro.
Viceversa come sarebbe stato interessante se l'intervento finale l'avessero fatto fare a
Jean Servier!
Autore: Ludwig Wittgenstein
Titolo: Note sul "Ramo d'oro" di Frazer
Editore: Adelphi Edizioni S.P.A.
Copertina: brossura
Pagine: 98
Anno di pubblicazione: Novembre 2006 (ottava edizione)
Dimensioni: 17,8 × 10,5 cm
EAN: 88-459-0183-1
Prezzo: 7,50 Euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| * HOME * | * LIBRI * |